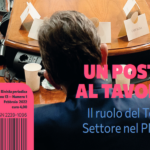“Posti per disabili chiusi in spazi separati, totale indifferenza degli addetti alla sicurezza quando non riesco a vedere lo spettacolo, mancanza di informazioni chiare, trasparenti e accessibili, tempi di risposta inadeguati”. E ancora, “uomini hanno approfittato della calca per strusciarsi addosso, anche in modo prepotente, o per mettere le mani dove nessuno aveva dato loro il permesso.”
Queste solo alcune delle tante risposte ricevute alla domanda “ti sei mai sentito/a discriminata/o a un evento di musica live a causa del tuo genere, etnia o disabilità?”. Il quesito si inserisce all’interno di un più complesso e articolato questionario somministrato su scala nazionale nell’ambito di un progetto di advocacy e sensibilizzazione, il Concerto Che Vorrei.
Nell’inverno tra il 2021 e il 2022, i volontari di KeepOn Live (la prima associazione di categoria dei live club e festival italiani, nonché capofila del progetto) con penna e taccuino alla mano hanno iniziato a immaginare il concerto che avrebbero voluto. Professionisti volontari con un forte senso di responsabilità per il loro ruolo di rappresentanza del mondo dell’arte e della musica dal vivo e con la consapevolezza che per renderlo davvero accessibile e inclusivo è più che mai necessario rimboccarsi le maniche.
Hanno scritto il Concerto Che Vorrei con l’idea di sensibilizzare, smuovere le coscienze di chi vive di musica, di chi ascolta la musica dal vivo, di chi supporta chi fa musica, di tutti noi. Il lavoro è stato impostato su tre anni, con fine prevista a dicembre 2024, promuovendo un percorso partecipativo che intende perseguire un rinnovamento del settore musicale e una maggiore inclusione, specialmente per quanto riguarda i temi di gender equality, disabilità, inclusione sociale e diversity. Hanno iniziato creando e poi somministrando tre tipi di questionari diversi (per il pubblico dei concerti, per gli/le artisti/e, per professionisti del settore) in quindici tappe diverse, tra festival e concerti, in tutta Italia, riuscendo a raccogliere più di 400 risposte. In parallelo sono stati organizzati tre workshop, pensati con la stessa tripartizione di utenza dei questionari, in cui addetti ai lavori, cittadinanza e artisti hanno lavorato per costruire il concerto ideale da tutti i punti di vista, facilitati dal lavoro di Bam! Strategie culturali, una cooperativa che accompagna festival, teatri, distretti culturali, enti territoriali, università, fondazioni e realtà del privato sociale sul tema del management culturale.
“È evidente che ci sia ancora tanta strada da fare per rendere il mondo dell’arte e della musica dal vivo realmente accessibile. Spinti da questa convinzione abbiamo impostato sin da subito le nostre azioni coinvolgendo in egual misura i protagonisti di tutto questo: il pubblico, gli addetti e le addette ai lavori e gli artisti e le artiste. Si tratta di un sistema triangolare interdipendente. Un pubblico senza arte non esisterebbe; un artista senza gli addetti ai lavori non potrebbe fare il suo lavoro. È una questione di co-responsabilità! Rendere accessibile e inclusiva l’arte, la musica è solo una porzione di un lavoro che in realtà abbraccia molti altri settori. I dati confermano un reale problema di gender gap, di discriminazione e razzismo in moltissimi segmenti del nostro settore e della società in generale”, racconta Gaianè Kevorkian di KeepOn Live e referente del progetto.
Ciò che emerge chiaro dai questionari è una netta differenza di percezione tra chi, nel mondo della musica, partecipa come pubblico e chi come addetto e addetta ai lavori (sia dietro le quinte e che sul palco). Per il primo, alte percentuali di persone, principalmente donne e disabili, hanno risposto di aver subìto discriminazione ma soprattutto che non sanno e non saprebbero a chi rivolgersi in caso di molestie. Buona parte degli addetti ai lavori hanno risposto sostenendo di avere personale sufficientemente formato e sensibile per prevenire e intervenire in caso di bisogno.
“Quello che ci raccontano i questionari è che c’è in primis scarsa consapevolezza e sensibilità”, afferma Josie Cipolletta, co-founder di Equaly, partner di progetto, è la prima realtà italiana che si occupa di parità di genere nell’industria musicale, composta da donne e persone che si identificano in un genere sottorappresentato.
“Non è cattiveria. È una questione culturale, sociale. Si ragiona troppo sul proprio vissuto e difficilmente si è in grado di metterci nei panni dell’altro. Le migliorie sono faticose, sono costose (spesso senza valutare i benefici sul lungo periodo) e difficili da implementare anche se questo vorrebbe dire portare nuovo pubblico. Rendere più accessibile il mondo della musica avvicinerebbe molte più persone. Come addetta ai lavori, dietro le quinte, mi rendo conto che noi donne abbiamo sempre gli stessi ruoli. Infatti, se ci pensate ci sono pochissime produttrici, pochissime direttrici artistiche. E non è certo per mancanza di competenze. Viviamo in una bolla dove il primo lavoro da fare è a livello culturale, formativo, come società civile, giorno dopo giorno.”
Cosa vuol dire discriminazione? Qual è la differenza tra genere e orientamento sessuale? Che cos’è l’abilismo? E l’etnia? Equaly, Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), con il supporto di Csv Milano, hanno fatto un primo tentativo di costruzione e promozione di un glossario consultabile e pubblico. Un semplice ma potente strumento, previsto dal progetto, per fare in modo che chiunque si imbatta nella comunicazione del mondo della musica, sia come utenza che come promotore, possa dare nomi, definizioni e allo stesso tempo riconoscersi in categorie, varietà e soggettività spesso sotto rappresentante o poco conosciute ai più.
“Bisogna intervenire sotto pelle, insistere sul dialogo, su una comunicazione efficace e inclusiva. Ci vuole più attenzione e più cura di tutto ciò che ci circonda. Come addetti ai lavori, volontari e attivisti ci confrontiamo spesso con il panorama europeo dell’industria musicale e ci rendiamo conto che in Italia siamo ancora poco innovativi, faticosamente al passo con i tempi e con le esigenze delle nuove generazioni”, continua Gaianè. Il glossario intende accompagnare e supportare l’idea della musica come importante collante sociale e poiché i concerti svolgono anche una funzione sociale e di appartenenza a un tempo a uno spazio collettivo, oggi risulta fondamentale e ancora necessario potersi riconoscere in un linguaggio comune condiviso e rispettoso delle differenze.
Il Concerto Che Vorrei si posiziona come progetto pilota per facilitare e promuovere un cambiamento di prospettiva, per lanciare buone pratiche e dimostrare che a volte rendere un concerto accessibile è molto più semplice di quello che sembra: “Sono abituato al fatto che facciano pagare il mio accompagnatore e non me, proprio perché disabile”, spiega Marco Rasconi, presidente nazionale di Uildm, “L’agevolazione e lo sconto hanno senso perché la vita di un disabile è mediamente più costosa; tuttavia, la completa gratuità delegittima il disabile in quanto spettatore/spettatrice, come pubblico del mondo della musica e dell’arte. Spesso proponiamo di fare 50 e 50. A livello economico non cambia nulla, ma azzerare il costo di uno dei due vorrebbe dire azzerare uno dei due”.
Rasconi, da anni, lavora per sensibilizzare e favorire un cambiamento culturale non solo per e con i disabili, bensì come comunità, come società civile. Racconta di aver aderito con grande entusiasmo al progetto proprio perché valorizza l’unicità dell’inclusione e non spacchetta le categorie e gli interventi. La segmentazione ci porta inevitabilmente al rischio di arrivare al punto di trovarsi di fronte categorie non calcolate: “e se la disabile fosse donna, migrante e omosessuale? O se fosse il cantante stesso disabile? È per questo che l’innovazione di un progetto così sta nell’affrontare la fragilità e le sotto rappresentanze a tutto tondo. Quando incontro i ragazzi nelle scuole cito spesso la questione delle strisce che delimitano i parcheggi per i disabili e per le donne in gravidanza. Non solo, nel 2024 evidentemente ce n’è ancora bisogno ma in pochi le rispettano. E’ un problema solo per i disabili? No. E’ di tutti e tutte noi. La mia libertà si completa con la tua!”, conclude Marco Rasconi.
Questo esperimento di volontariato e attivismo sta vivendo l’ultimo anno previsto dalla progettazione, con il sostegno del ministero della Cultura, e sta già lavorando alla sua sostenibilità per fare in modo che non rimanga solo un primo tentativo. A Torino, Roma, Palermo, Milano e in molte altre città di Italia sono già state sperimentate migliorie, buone pratiche con riscontri più che positivi. Si parla di semplici tappi per le orecchie, zainetti e pedane che trasmettono vibrazioni, adibizione di safe space in cui chiunque si trovi in difficoltà e abbia bisogno possa trovare conforto e confronto con esperti, inclusione nei palinsesti di talk e approfondimenti con persone promotrici di spunti di riflessione sull’inclusione a 360 gradi.
L’obiettivo è fare in modo che tutto questo non rimanga solo una sperimentazione innovativa, lasciata nelle mani di pochi coraggiosi bensì normale prassi. Questo non è possibile senza il dialogo, senza una triangolazione pubblico-artisti-addetti ai lavori, coesa e in continuo spirito di reciprocità.