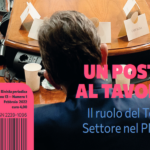Il periodo natalizio concretizza un quarto delle donazioni degli italiani. Un sondaggio YouGov del 2021 dice che il 16 per cento di persone dona solo a dicembre e il 26 per cento sia a dicembre che in altri momenti dell’anno. Considerando che si dichiarano donatori il 44 per cento di questo campione, i dati sembrano suggerire che solo un quinto della popolazione (18 per cento) è pronto a cogliere l’invito a donare in altri periodi dell’anno.
Ma davvero? E’ questo il nostro più ampio terreno di potenziale connessione con i cittadini che non conoscono in prima persona il nostro lavoro e la nostra causa? In realtà, peggio. Dai dati Istat si ricava che circa il 13 per cento di italiani fanno donazioni in denaro. Pochi, ma sempre di più dell’8 per cento che è impegnato nel volontariato organizzato.
Quindi il terzo settore si è giustamente preoccupato degli effetti del polverone mediatico scatenatosi attorno alla nota influencer trovatasi coinvolta nella pubblicizzazione di un prodotto, che sembrava parte di un’iniziativa di beneficenza, ma non lo era. Ed è bene pertanto ragionarci su a freddo, sotto l’ombrellone e magari leggendo sul serio il nostro Bilancio sociale, per non ritrovarci di nuovo a fine anno a competere in una corsa a ostacoli, scarsamente autodeterminata.
Forse però, sul momento, non ci siamo preoccupati abbastanza, e sufficientemente velocemente, di questioni di fondo. In primo luogo, a non svelare al grande pubblico la trappola del tutta l’erba un fascio (ne abbiamo parlato anche nello scorso numero di VDossier, ndr). In secondo luogo, a limitarci a leggere la reazione dei cittadini meramente in termini di comportamento dei consumatori.
Il danno dell’immagine si è riverberato su tutto il terzo settore, in particolare sulle associazioni che propongono iniziative di consumo etico o anche crowdfunding. Queste offrono modalità di cittadinanza consapevole a basso investimento ma ad alto rendimento personale. Il ragionamento è: mi costa poco scegliere un prodotto piuttosto che un altro e invece mi fa sentire tanto bene con me stesso. Si tratta di micro-scelte individuali: se non la posso fare velocemente e in sicurezza –se non posso agire una delega di fiducia immediata– l’attimo è fuggito.
Ma ne rimane la traccia: si erode la fiducia. In chi, chiunque, mi proponga qualcosa vestito di buona causa. Risiede qui il vero danno: è una questione sostanziale, non di immagine. Per questo motivo lo Stato si è sentito chiamato in causa, a difesa del bene comune: la fiducia è la trama relazionale della comunità democratica.
Il Consiglio dei ministri ha approvato, il 25 gennaio 2024, un disegno di legge (ddl beneficenza) che detta obblighi precisi sulle informazioni da dare in maniera chiara e trasparente per chi commercializza e promuove i prodotti in cui parte dei proventi è destinato in beneficenza. Questo provvedimento normativo non riguarda il terzo settore: i soggetti del ddl beneficenza sono gli attori commerciali, cioè le imprese e i professionisti. Ma l’impatto di questa nuova normativa cala un ulteriore peso su tutto il terzo settore. Quel che nasce, a prima vista, come una chiara e veloce dimostrazione della cura dello Stato per gli interessi generali a tutela della fiducia pubblica si rivela, nei fatti, un’ulteriore barriera nella delicata triangolazione dei rapporti tra le associazioni, l’amministrazione pubblica e i cittadini.
Un’ulteriore tecnicalità burocratica da gestire, senza che aggiunga alcun puntello a salvaguardia e valorizzazione del nostro capitale reputazionale collettivo.
Le attività di raccolta fondi svolte dagli Ets sono già regolamentate dal decreto 9 giugno 2022 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, linee guida in tema di raccolta fondi degli Ets. Il rispetto di queste norme fa parte di un sistema molto strutturato delle pratiche strettamente normate di gestione e trasparenza che sono alla base della distinzione dell’Ets –marchio di garanzia di pubblica fiducia. A questo serve il Runts (Registro unico nazionale del terzo settore), questo era l’obiettivo a cui tendere del Codice del Terzo settore. È stata un’occasione mancata non rimarcare questo nell’occhio del ciclone di zucchero velato del caso pandoro, magari richiamando il legislatore a gestire diversamente la regolamentazione del settore profit in materia di beneficenza. Se le imprese avessero un beneficio, o anche delle semplici agevolazioni operative, a proporre iniziative benefiche in partenariato con un Ets –e non da sole, e non improvvisate, e non con chiunque– guadagneremmo tutti, per primi i cittadini.
E si metterebbe a frutto un investimento decennale, le prime linee guida, proposte dall’allora Agenzia per le onlus, datano al 2010. Importante però in tutta la vicenda è non confondere, nel nostro approccio, la scelta degli scalpelli con il disegno della statua: le regole di trasparenza, come la padronanza dei social media, non sono l’obiettivo, ma solo dei mezzi per raggiungerlo.
Concentrarsi su queste vestigia del mantra della professionalizzazione del terzo settore ci mantiene prigionieri del pensiero egemonico della managerializzazione necessaria che ci perseguita dagli anni Novanta. Come se il mondo non fosse già in un periodo di cambiamenti radicali. Cambiamento climatico, demografico, geo-politico, intere placche teutoniche del mondo come l’abbiamo conosciuto si stanno muovendo. È necessario pensare come rimanere in piedi come forme organizzative capaci di proporre e restituire ai cittadini un senso di riconoscimento, speranza, giustizia, fiducia.
Perché la fiducia non è solo quella dei consumatori o delle imprese nella possibilità dello sviluppo economico, come minuziosamente misurata mensilmente dagli uffici statistici nel quadro di Eurostat, ma anche uno degli elementi fondativi dell’identità organizzativa di enti con missione pubblica. La considera tale uno studioso di etica, Kevin Wm Wildes, gesuita pugile, componente del consiglio etico che ha guidato la ricostruzione del tessuto urbano di New Orleans in seguito alla devastazione causata dall’uragano Katrina, nel libro pubblicato nel 2023 intitolato “Etica organizzativa e integrità morale nelle società secolari”.
Unitamente alla missione e alla responsabilità morale, il fattore fiducia è ritenuto parte essenziale in particolare per gli organismi della società civile, attivi nei settori di educazione e di salute, che si occupano di categorie vulnerabili e in quanto tali terreno sostanziale su cui poggiare gli strumenti di rendicontazione sociale. Che non sono anonimi strumenti tecnici ma, nella teoria di Wildes “infrastrutture per l’etica”.
Sono questi i concetti sottostanti al brand, direbbero gli esperti di marketing, della nostra distinzione di Ets. Dicono adesso esattamente quel che ci è stato tramandato come intuizione fondativa dei movimenti del volontariato, della cooperazione e dell’associazionismo. Identità degli enti del terzo settore e fiducia pubblica, che è un’osmosi tra la fiducia dei cittadini e quella dello Stato, è quanto fa la differenza nell’orientamento dei cittadini a dare supporto alle iniziative proposte dalle associazioni.
Il supporto dei cittadini si esprime principalmente in tre modi: donazioni, attivarsi come volontari, pubblicità positiva informale. Le prime due sono perseguite come obiettivo esplicito dalle attività promozionali e filoni di lavoro e riflessione consolidati. La terza invece, quell’apparentemente effimero –questi li conosco, questi sono bravi, io sostengo questi, detto con minimo dispendio di risorse, sia di persona che nel mondo digitale– rappresenta un importantissimo ma sottovalutato aspetto che costruisce la fiducia pubblica, che rappresenta l’ecologia generale in cui tutto il nostro operato si inserisce.
L’ecologia della fiducia pubblica coinvolge quindi il terzo settore sia come destinatario/obiettivo sia come attore/costruttore della fiducia dei cittadini. In un contesto allarmante generale: “L’Italia si distingue per livelli di fiducia istituzionale relativamente bassi.
Le uniche istituzioni che riescono a ottenere sufficienti livelli di fiducia dei cittadini sono le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco. Per il resto la fiducia nelle istituzioni della democrazia è sotto la sufficienza. Si tratta di caratteristiche di lungo periodo, stabili attraverso tutto il decennio analizzato”. (Istat, 16 maggio 2022) È importante quindi interrogarsi su cosa muove –cosa costruisce e contribuisce, e cosa distrugge ed erode– il fatto che i cittadini confidino che le associazioni agiscono per il bene pubblico.
Dagli studi internazionali si apprende (utile la rassegna in Voluntas 2002, 33:5) che le ragioni principali della diminuzione della fiducia pubblica possono essere ricondotte agli aspetti che riguardano proprio la specifica natura identitaria del terzo settore, di cui si ragionava prima. Si tratta del cosiddetto mission drift (deriva di missione) che riguarda lo spostamento degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi su dimensioni etiche strategicamente diverse da quelle originarie. La deriva di missione è legata a doppio filo, in un rapporto causale in effetti circolare, da cane che si morde la coda, con altri due fenomeni individuati come con-cause della perdita di fiducia del pubblico generale in enti di terzo settore: la perdita di autonomia e la commercializzazione.
Di questi ultimi due aspetti si discute anche in Italia. Della deriva di missione, no. Perché riguarda aspetti valoriali e chiama in causa il nostro posizionamento sistemico. Richiede un investimento in auto-critica e in critica sociale che si basa su processi complessi, conflittuali, dolorosi. Per questo non li facciamo. E invece dovremmo.
Una ricerca del 2022 commissionata dalla Commissione governativa per le charity (organizzazioni di beneficenza) dell’Inghilterra e del Galles sulla fiducia pubblica, individua le seguenti quattro aspettative che il pubblico ha, per considerare le charity degne di fiducia:
• Che una grande proporzione dei fondi sia destinata alle attività dirette;
• Che realizzino effettivamente l’impatto che si prefiggono;
• Che le modalità di lavoro che usano per perseguire l’impatto che si prefiggono sia consistente con lo spirito di missione;
• Che tutti gli enti contribuiscano alla solidità della reputazione generale aderendo ai principi sopra indicati.
In questo contesto di aspettative, la fiducia decresce, perché il pubblico giudica negativamente i fenomeni individuati sopra: la commercializzazione, la perdita di autonomia e la deriva di missione. In Inghilterra e Galles la fiducia del pubblico ha registrato nel 2022 il minimo storico di 6,2 su 10, non male considerando che il massimo, nel 2014, era 6,7 e che il governo arriva a guadagnarsi una metà di questa fiducia, il 3,2.
E invece, è necessario guardare oltre. Perché rispetto alle indicazioni che ci danno sul momento storico attuale e le responsabilità pubbliche che esercitiamo, i dati sono devastanti. Dieci anni prima (nel 2012) il 76 per cento del campione della stessa ricerca (eseguita dalla casa di consulenza Yonder) riteneva che le charity fossero essenziali o molto importanti per la società. Al momento della ricerca (nel 2022) pensa siano così importanti solo il 56 per cento degli interpellati.
L’altro dato allarmante è che la differenza di orientamenti tra le classi sociali continua ad aumentare. Nel segmento della popolazione che vive in aree urbane economicamente deprivate, ad alta intensità abitativa e ad alto tasso di multiculturalità, la fiducia è caduta di 10 punti percentuali in un anno (al 46 per cento). Grosso modo, chi è benestante è due volte più propenso a concedere fiducia al terzo settore (66 per cento) di chi vive in condizioni di povertà (37 per cento).
Con chi stiamo parlando? A chi guardano i nostri obiettivi di missione?